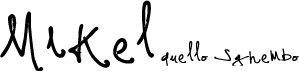Senza cicatrici
Senza cicatrici  No Comments
No Comments >
Arrivavo protetto da un finestrone da pullman sgranando gli occhioni fin dall’imbocco del raccordo anulare.
Io, bimbo sul lungotevere, mi soprendevo a pensare: è giusto, sarà Capitale perchè ci sono più automobili in giro rispetto alle quattro che scorazzano su e giù nel mio paesello e che al volante hanno sempre la stessa gente.
La stessa gente…
C’era il Fausto, il panettiere: guidava il Fiorino del pane sempre bianco e profumato.
Mi ricordo del Brughì, che girava con una 127 rossa con la targa scassata legata al cofano con un pezzo di spago e aveva sempre caramelle sul cruscotto.
Il Marletta invece passava il sabato col furgoncino Volkswagen dai fari rotondi. Faceva il fruttivendolo ambulante.
Come clackson aveva una di quelle trombette con la palla di gomma nera attaccata all’estremità.
Lui schiacciava due tre volte il posteriore e quella docile starnazzava.
Era il segnale: mia madre sentendolo arrivare scendeva nella piazzola, cortigiana assieme ad altre donne del quartiere spuntate dal nulla sempre e chissà da dove.
Il Marletta posava arance e mele sulla vecchia bilancia a mano e faceva sempre il prezzo che voleva grazie alla velocità con la quale faceva finta di pesare.
Credo sia morto poi. Di cosa o come, non l’ho mai capito.
Infine c’era il vecchio Giampiero , il benzinaio che stava sempre stralunato accanto alla sua pompa di super.
Lui dava la vita motorizzata alle persone della mia infanzia, ma non l’ho mai visto guidare.
Quasi ne sapesse di più. Di più di che cosa poi, non l’ho mai capito.
Avevo imparato a riconoscere questi personaggi dal rumore dei tubi di scappamento.
Mi mettevo a cavalcioni infilando le gambe fra le stecche della ringhiera del balcone che s’affacciava giusto giusto sopra una curva a gomito, dove se passavano dovevano per forza rallentare.
Se un giorno uno di loro non stava bene lo capivo ormai non più dagli occhi gialli che intravedevo al di là del parabrezza, ma dallo sfiato roco della marmitta e dalle nuvolette grigiastre che sbuffavano sull’asfalto.
Loro eran sempre loro e avevan sempre le stesse auto: mai immaginavo allora che una persona potesse cambiarla.
Credevo che uno ci nascesse con la sua macchina e con quella guidava fino a quando non si stancava di farlo.
Oppure, pensai un giorno che mi vennero teorie distorte dopo aver mangiato un mottarello, che fosse l’auto stessa a non volerne più sapere del propietario e che si fermasse all’improvviso, in mezzo alla strada, senza più ripartire.
Semplicemente non ne aveva più voglia e barattando la sua anima col cielo lasciava sull’asfalto la carrozzeria. Immobile.
E l’asfalto era grezzo, da poveretti, tutto squassato e mai rifatto nemmeno una volta.
Ma si conoscevan tute le buche e alla fine ci si affezzionava pure.
A Roma no. Cioè intendiamoci: le buche c’erano, e anche tante.
Solo che il pullman che mi stava scarrozzando se le trovava davanti all’improvviso e non poteva evitarle.
Io, di quelle buche non ne conoscevo neanche una e mi facevan paura nonostante a star così in alto, comodo e rannicchiato nel sedile, nemmeno sentivo le vibrazioni quando ci passavo sopra.
Insomma la grande città mi era estranea e per farmela amica cominciai ad osservare ovviamente le automobili, sperando assurdamente di riconoscerne qualcuna che da Bergamo fosse venuta fino a lì solo per non lasciarmi solo.
Era inutile ovviamente, ma quel giochetto m’affascinava.
Erano gli inizi degli anni ’80 e quando tornai dalla mia gita scolastica dalla capitale quel che mi rimase negli occhi fu l’incredibile numero di Cinquecento che vidi sparse in ogni angolo.
Fiat 500.
Sulle aiuole, in mezzo alla strada, parcheggiate in terza fila o di traverso sui marciapiedi.
Ovunque c’erano cinquecento di tutti i tipi: elaborate, classiche, col tettuccio di gomma nera, rigate lungo i fianchi, piene di pupazzetti, senza un copricerchione, con gli adesivi argentati vicino alle maniglie delle porte e una, solo una ne vidi, con lo stemma della Ferrari in mezzo al cofano.
Mi piaceva quel macinino: rendeva alla metropoli un senso di formicaio a misura d’uomo.
Piccola com’era quella scatolina che arrivava da Torino contenava gli uomini, il loro girovagare disperso e caotico per la città, le loro passioni e i quattro fogli di giornale per nasconderle ad occhi estranei.
Anche se allora l’Amore era cosa da grandi e il massimo scandalo per noi bambini era immaginarsi al suo interno i quattro elefanti pigiati stretti stretti.
Al paesello, una volta tornato, ci misi un attimo per riadattarmi allo scorrer lento e ripetitivo del poco traffico lungo l’unica strada provinciale.
Da noi, cinquecento ce n’ erano invece molto poche.
Cosa strana addirittura era vedere quel piccolo quattroruote simpatico arrancare fra le curve come estraneo in un mondo che non gli apparteneva.
Non smisi per lungo tempo di sedermi a cavalcioni sul mio balcone e di ascoltare il suono delle marmitte.
Ogni volta che in lontananza riconoscevo il suono di una ‘doppietta’ mi preparavo sorridendo.
Mentre ripensavo alla mia gita, balzavo in piedi e chiudevo gli occhi fino a quando la cinquecento non passava proprio sotto il naso.
Allora li aprivo e la seguivo con lo sguardo accompagnandola fino a quando non scompariva, questa volta per volontà sua, dietro la curva.
E ogni volta mi sembrava per un istante d’essere di nuovo nella capitale.
Ci son tornato, poco tempo fa, a Roma.
Ora son tutte Smart.